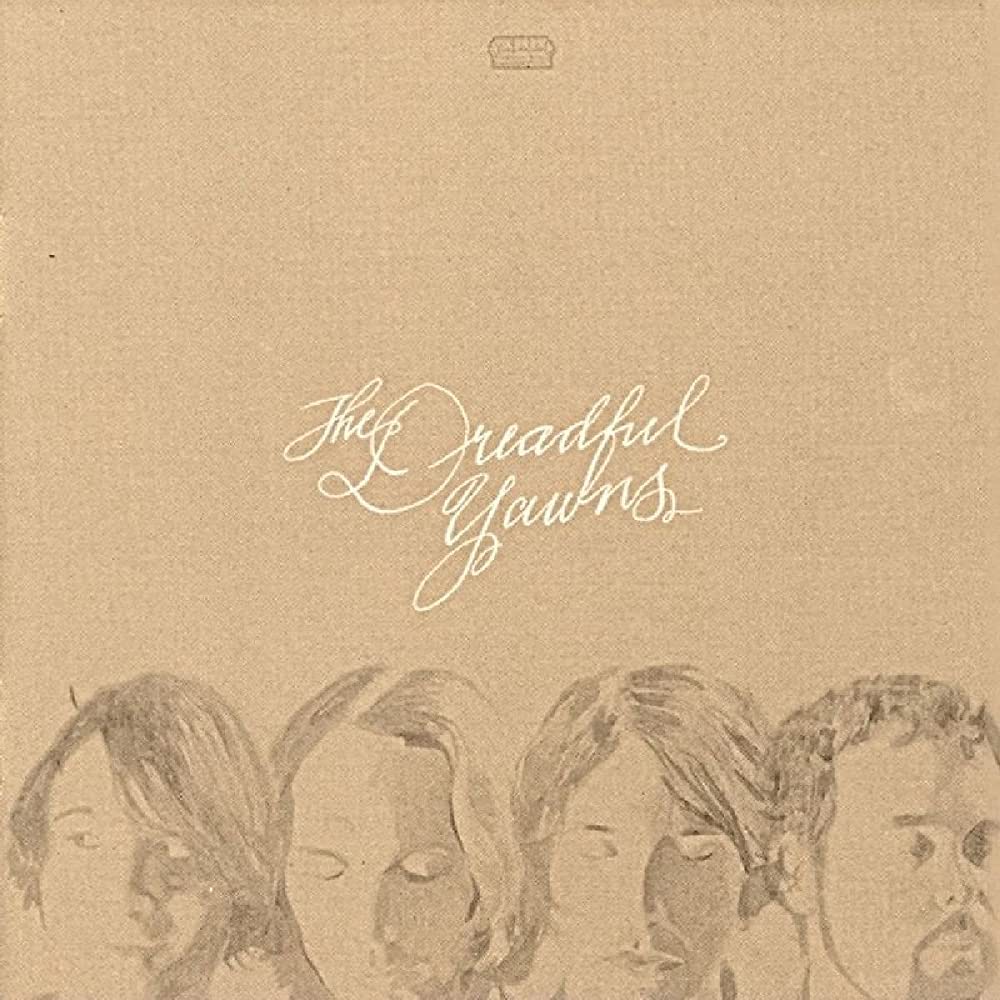Nel gennaio del 1981 New Musical Express stampa la prima di una lunga e gloriosa serie di cassette. Si intitola C81. L’intento è quello di documentare la scena indipendente britannica con un supporto acustico che possa rendere tangibile quello di cui la rivista profetizza sulle sue colonne. Alcuni protagonisti sono già delle stelle. I reduci della stagione ska britannica come Specials o Beat ad esempio. O il santone Robert Wyatt. Oppure i Buzzcocks, le Raincoats, Ian Dury, i Pere Ubu.
Altri sono emergenti. Timidi ma risoluti, come tutti gli emergenti. Tre di loro vengono dal piccolo salvadanaio della Postcard Records. Come dire, cartoline dalla Scozia. Una di queste è scritta con calligrafia incerta ed adolescenziale da un tale Roddy Frame. Sedici anni, all’epoca. We Could Send Letters dice. Appunto.
È la nascita artistica degli Aztec Camera, in breve tempo messi sotto torchio dalla Rough Trade per cagare canzoni sospese tra la gracilità del giovane guitar-pop scozzese e l’appeal “adulto” del cantautorato americano di gente come Paul Simon, Jackson Brown, David Crosby. Perché Roddy, a dispetto della giovane età, è uno che ha la capacità di scrivere canzoni immediate e leggere senza cadere nella mediocrità del pop da boyband. Ha un linguaggio per nulla banale di chi ha letto Keats ed ha provato a tagliarsi con la lametta dell’amore. E delle dita che sanno pizzicare le corde della chitarra con ricercatezza sopraffina, alternando la luminosa letizia degli scatti funky (Walk Out to Winter) alla discrezione sofisticata del jazz (Release), brillanti trame jingle-jangle (The Bugle Sounds Again), il tocco fiero delle vecchie macchine antifasciste di Woody Guthrie e Pete Seeger (Down the Dip) e arpeggi rockabilly (Queen Tattoos, pubblicata come retro per Pillar to Post). Un gruppo capace di fare ingelosire Marr, sin dagli inizi della storia (il chitarrista ammetterà in seguito di aver scritto This Charming Man in un impeto di competizione con la band scozzese dopo aver sentito lo scintillìo della chitarra di Frame su Walk Out to Winter. Personalmente credo fosse poi arrivato ad odiarlo dopo aver ascoltato il tappeto di chitarre che si stende sotto The Boy Wonders, NdLYS). Un talento, quello del giovane Roddy, che anni dopo gli assicurerà una richiesta di “soccorso” da parte di Morrissey per assicurare un futuro agli Smiths dopo gli scazzottamenti verbali col vecchio compare Johnny Marr. Una fucina, quella degli Aztec Camera, da cui gli Smiths avevano già attinto un altro fuoriclasse come Craig Gannon.
High Land, Hard Rain è il balcone che accoglie l’apertura delle imposte che danno sulla camera azteca e su Roddy Frame, il ragazzino che tradì David Bowie per Stevie Wonder, senza pentirsene mai.
Franco “Lys” Dimauro